QUARTO FLEGREO
E I NAZISTI
MICROSTORIA
DI UNA GUERRA
Documenti ingialliti, si va dai resoconti parlamentari su interrogazioni vecchie di settant'anni fino ai memo militari su basi e armamenti. Indagini fotografiche che 'dissotterrano' - dalle masserie abbandonate fino alle grotte di collina - i rifugi antiaereo del secolo scorso. Infine - forse l'impatto più forte - ci sono i ricordi degli anziani, che del 1943 e del '44, di quei mesi fra l'armistizio di Cassibile e la liberazione di Napoli e del Sud, conservano emozioni intense e aneddoti drammatici. Come nelle parole della signora Fiorentina Di Falco: "Mia madre Giovanna Marano, all'arrivo dei tedeschi, si buttò giù da una siepe per raggiungere il ricovero della masseria 'ncopp o' mont. I tedeschi la videro e scoprirono il nascondiglio, ma non fecero alcuna rappresaglia".

Si presenta così, come una carrellata di microstoria e microstorie, "Quarto 1943", uno studio dell'archeologa Raffaella Iovine con la consulenza di Simon Pocock che sarà presentato sabato 20 maggio alle 17,30 nel comune di Quarto, a nord di Napoli, nel cuore dell'area flegrea, nella chiesa di Santa Maria libera nos a scandalis. La ragione di questo tuffo nel secolo scorso è l'anniversario, ottant'anni, di un episodio centrale della guerra in questi luoghi, l'esplosione del deposito di munizioni di Quarto, appunto.
Ma al di là della causa occasionale, la celebrazione punta a rinverdire la memoria dell'occupazione nazista e della 'tensione precaria', come racconta l'introduzione, 'tra regime fascista e popolazione'. Lo studio nasce sotto il 'patrocinio morale' dell'Anpi di Napoli e del gruppo archeologico dei Campi Flegrei, e meriterebbe sforzi simili in tutti i comuni del Golfo, che prima e dopo le famose Quattro Giornate furono protagonisti, se non di una Resistenza organizzata, certamente di una miriade di atti piccoli e grandi di sabotaggio, di rivolta e di eroismo.
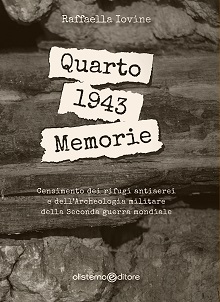
"Quarto 1943" racconta la militarizzazione della città di Quarto, che già nella prima guerra mondiale ospitava un deposito di munizioni del Regio esercito, ribattezzato 'La polveriera dei tedeschi' quando il 10 settembre del '43 le forze di Hitler in ritirata lo fecero saltare per sottrarlo agli alleati. E poi il mosaico di chi è ancora vivo, le immagini di quel giorno e di quelli che seguirono; infine le polemiche dopo la guerra sull'opportunità di costruire nuove santabarbara.
Ma soprattutto l'autrice, coadiuvata da altri studiosi, intervista uno a uno, nell'arco di vari anni, chi a quegli eventi è sopravvissuto, e confronta le parole con i non molti documenti che rimangono a raccontare la logistica militare e civile di quei mesi: in particolare la dislocazione delle difese e gli spazi di ricovero antiaereo in grotte nel tufo, ponti e gallerie sotto la Montagna spaccata, l'imponente opera stradale romana che unisce Pozzuoli a Quarto aprendo la strada verso l'Appia e Roma.
Ne esce l'amarcord di gente in balìa della violenza e della guerra, che se fino a un anno fa poteva sembrare lontano da noi adesso, dopo l'aggressione dell'Ucraina, riattualizza quei drammatici ricordi. Come si capisce dal racconto di Giovanni Quaranta: "Antonio De Vivo fu ucciso dai tedeschi nei pressi della scuola Gobetti. Un soldato gli intimò di fermarsi ma lui, non comprendendo il tedesco, si incamminò lo stesso. I tedeschi gli fecero scavare un fosso, poi lo fucilarono." E davvero sembra di sentire le parole degli scampati di Bucha.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI
© Tutti i diritti riservati
