MA COME PARLA
L'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE?
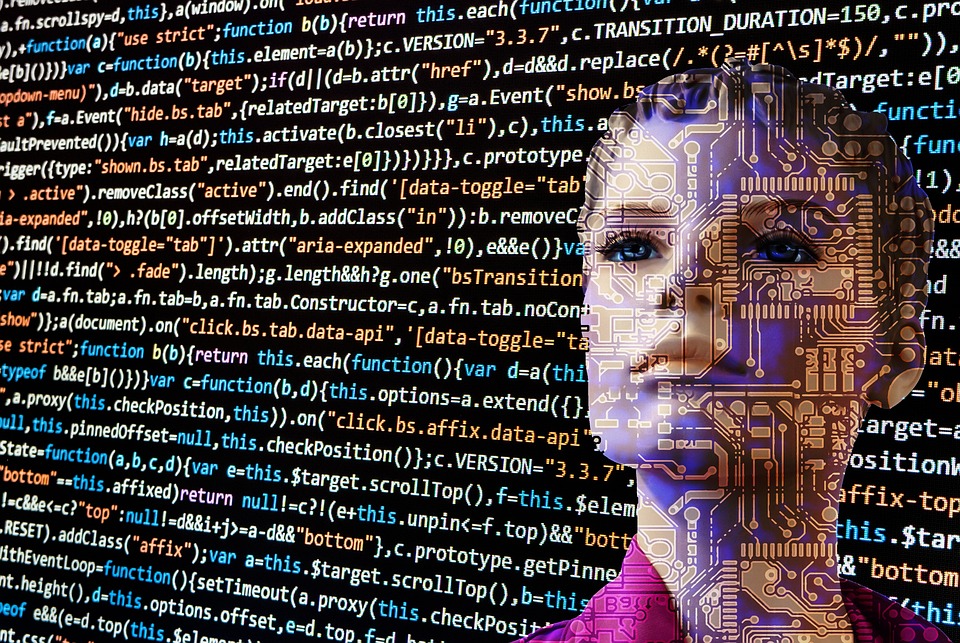
“Potrai partecipare quando qualcuno te lo permetterà”. Se presentandovi a una riunione in ufficio all’ora stabilita qualcuno vi accogliesse con queste parole, quale sarebbe la vostra reazione? E invece quando il messaggio perentorio appare sotto la schermata video di una qualsiasi riunione di Google Meet a cui si è stati regolarmente invitati, pazienza. Si accetta senza battere ciglio. Non che altre funzioni dell’applicazione abbiano un linguaggio più rassicurante. Parlando di persone da coinvolgere in una riunione si usa sì il termine “invitati”, ma poi per l’amministratore scattano gli imperiosi “Ammetti”, “Blocca”, Rimuovi”.
Sarà anche colpa della traduzione dall’inglese, ma per la tecnologia le sfumature non sembrano esistere. Nella lingua come nella varietà dei percorsi predeterminati offerti all’utente. Sono dettagli, secondo i tecnologi. Ma per chi – come chi scrive – non usa Alexa, non parla con Siri, si disorienta coi risponditori automatici dei call center e tende a ricambiare i saluti del messaggio registrato al casello autostradale, certi particolari appaiono evidenti. Come anche tutti gli errori di grammatica e l’uso a vanvera degli accenti nelle email e nei messaggi Whatsapp.
Le imprecisioni, e soprattutto la mancanza di sfumature, più che fastidiose risultano allarmanti. Il linguista Tullio de Mauro, scomparso nel 2017, a proposito dello scambio tra esseri umani sosteneva: “Utilizziamo solo in parte le potenzialità di comunicazione che ci offrono il linguaggio e la parola. Possiamo fare ancora molti passi avanti sulla via della comprensione reciproca e dell’intelligenza del mondo, purché l’uso del linguaggio sia anche educazione alla parola”. Ecco. Come non porsi allora il problema della tendenza esattamente opposta, cioè di quell’impoverimento del linguaggio che ha iniziato a manifestarsi con l’avvento del mondo digitale? Nell’era dell’umanizzazione della tecnologia, con il dilagare dei sistemi di conversazione automatizzata – le chatbot tipo Alexa, Siri e ora Chat gpt – appare doveroso pretendere la qualità anche della lingua “parlata” e “compresa” dall’intelligenza artificiale.
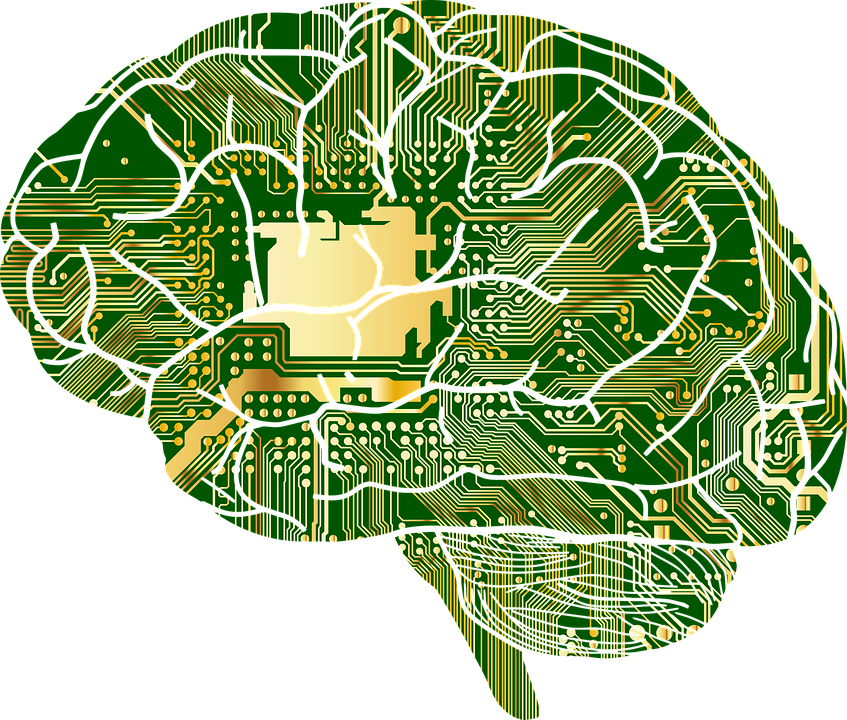
Per essere definiti intelligenti, bisogna essere anche intellettualmente sofisticati. Giusto per essere precisi, ecco la definizione di intelligenza secondo la Treccani: “Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all’adattamento; propria dell’uomo, in cui si sviluppa gradualmente a partire dall’infanzia e in cui è accompagnata dalla consapevolezza e dall’autoconsapevolezza, è riconosciuta anche, entro certi limiti (memoria associativa, capacità di reagire a stimoli interni ed esterni, di comunicare in modo anche complesso, ecc.), agli animali, spec. mammiferi (per es., scimmie antropomorfe, cetacei, canidi)”. Prima di riconoscerla alle macchine, tocca verificare la raffinatezza della loro varietà di funzioni.
E non è una questione di stile ed eleganza. A rendere l’intelligenza artificiale un pericolo non sono soltanto gli interessi delle aziende che la controllano o l’indipendenza che potrà in un futuro raggiungere dagli esseri umani che l’hanno creata, molto pesa anche la povertà degli strumenti che la programmano. Il rischio di dare vita a tanta “deficienza artificiale” è concreto. Il tema cruciale è chi insegna alle macchine ad essere intelligenti e come.

La supremazia della tecnologia sull’umanesimo, delle discipline scientifiche su quelle letterarie, non sembra rappresentare la strada giusta. Di fronte alla complessità delle sfide che ci attendono, abbiamo bisogno di tutte le risorse culturali di cui disponiamo. JM Olejarz nell’articolo “Liberal Arts in the Data Age”, comparso nel 2017 sulla Harvard Business Review, scriveva: “Agli studenti universitari che si specializzano in discipline umanistiche viene sempre fatta una certa domanda. Gli viene posta così spesso – e da così tante persone – che dovrebbe essere stampata sui loro diplomi. Quella domanda, fatta da amici, parenti, tutor, è 'Che cosa hai intenzione di fare con la tua laurea?'. Ma potrebbe anche essere 'Servono le discipline umanistiche?'. Secondo tre nuovi libri, la risposta è 'Parecchio'. Dalla Silicon Valley al Pentagono, le persone stanno iniziando a rendersi conto che per affrontare efficacemente le più grandi sfide sociali e tecnologiche di oggi dobbiamo pensare in modo critico al loro contesto umano, qualcosa che i laureati in discipline umanistiche sono ben addestrati a fare. Chiamatela "la vendetta dei nerd del cinema, della storia e della filosofia”.
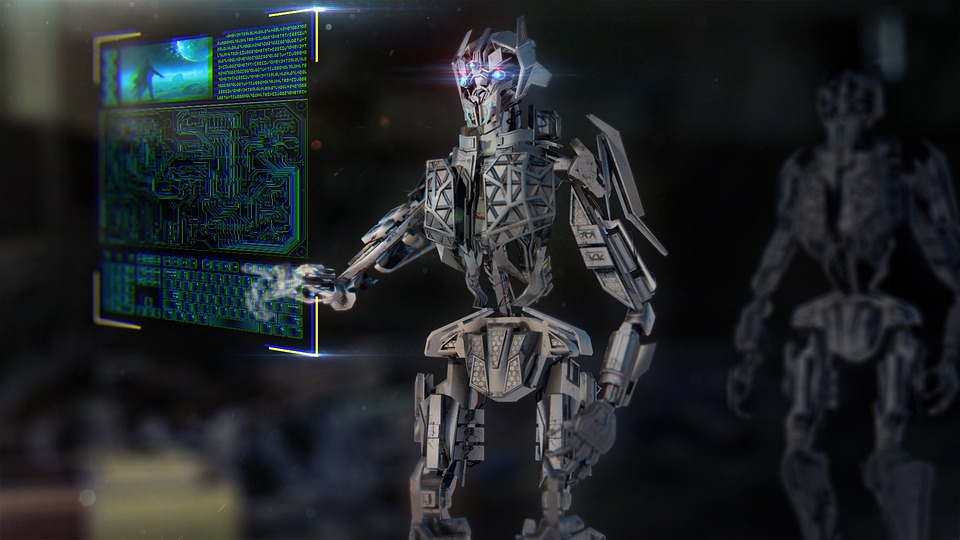
Non stiamo parlando di un fenomeno nuovo. Già nel 1959, il chimico e letterato Charles Percy Snow, tenne all’Università di Cambridge la lectio magistralis “Le due culture e la rivoluzione scientifica”, scatenando il dibattito sulla distanza venutasi a creare nella civiltà occidentale tra discipline umanistiche e scientifiche. Una delle voci che negli anni successivi prese parte al dibattito fu Primo Levi, chimico e scrittore, che così riassunse la sua posizione nella prefazione de L’Altrui mestiere (Einaudi, 1985): “Troppo chimico, e chimico per troppo tempo, per sentirmi un autentico uomo di lettere; troppo distratto dal paesaggio, variopinto, tragico o strano, per sentirmi chimico in ogni fibra. Ho corso insomma da isolato, ed ho seguito una via serpeggiante, annusando qua e là, e costruendomi una cultura disordinata, lacunosa e saputella. A compenso mi sono divertito a guardare il mondo sotto luci inconsuete, invertendo per così dire la strumentazione: a rivisitare le cose della tecnica con l’occhio del letterato, e le lettere con l’occhio del tecnico”.

E ancora: “Altrove, mi sono avventurato a prendere
posizione su problemi attuali, o a rileggere classici
antichi e moderni, o ad esplorare i legami trasversali
che collegano il mondo della natura con quello della
cultura; sovente ho messo piede sui ponti che uniscono
(o dovrebbero unire) la cultura scientifica con quella
letteraria scavalcando un crepaccio che mi è sempre
sembrato assurdo. C’è chi si torce le mani e lo
definisce un abisso, ma non fa nulla per colmarlo; c’è
anche chi si adopera per allargarlo, quasi che lo
scienziato e il letterato appartenessero a due
sottospecie umane diverse, reciprocamente alloglotte,
destinate a ignorarsi e non interfeconde. È una schisi
innaturale, non necessaria, nociva, frutto di lontani
tabù e della controriforma, quando non risalga
addirittura a una interpretazione meschina del divieto
biblico di mangiare un certo frutto. Non la conoscevano
Empedocle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe,
Einstein, né gli anonimi costruttori delle cattedrali
gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni
artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo
dell’inconoscibile”. Ecco. Potrà mai bastare un
algoritmo per spingerci consapevolmente oltre l’orlo
dell’inconoscibile?

