Trepca
dove crollò
la Jugoslavia
Dolore e storia nella miniera ribelle
Una recensione di
FLAVIO FUSI
A Trepca ci sono stato – con Bogdan e Miki – in un giorno d’estate del dopoguerra balcanico. All’ingresso della valle, la fabbrica gigantesca giaceva come un colosso atterrato, la carcassa spolpata di un dinosauro. Il vento del pomeriggio fischiava tra le impalcature rugginose e le finestre sfondate dei depositi in rovina, sollevando nuvole di polvere scura dall’imponente montagna nera di detriti vomitati dalle miniere abbandonate di Stari Trg: un milione di tonnellate di terra velenosa che rende sterile per chilometri tutta la zona a nord di Mitrovica e che incombeva allora sui tre campi rom di Zitkovac, Cesmin Lug e Kablare.
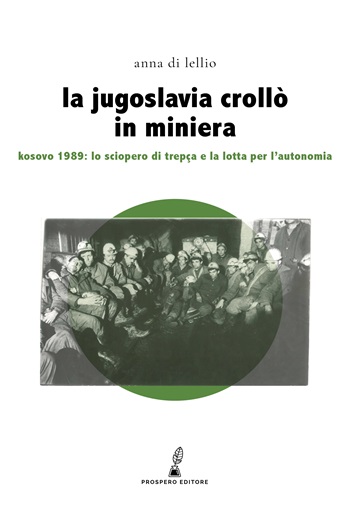
la Jugoslavia crollò in miniera
- kosovo 1989: lo sciopero di Trepca e la lotta per l'autonomia
di Anna Di Lellio
Prospero editore
18 euro
In quella prima decade degli anni Duemila eravamo in cerca di fantasmi dolenti: bambini morti avvelenati e madri rassegnate: una manciata di famiglie di “zingari” cacciati dalle loro case alla periferia di Mitrovica, profughi maledetti da serbi e albanesi e affidati all’incerta elemosina di pavide organizzazioni umanitarie. Succede sempre così, nel nostro mestiere di cronisti girovaghi: insegui la cronaca e non ti accorgi di calpestare la storia. A distanza di decenni, quella storia – la vera storia di Trepca - ce la racconta invece Anna Di Lellio, con il suo libro “La Jugoslavia crollò in miniera”: una inchiesta esemplare, nei toni di un romanzo storico, condotta con il rigore della studiosa e la passione della giornalista di valore.
I fatti: nel febbraio dell’89, tutti i 1300 minatori albanesi del complesso estrattivo di Trepca si rifiutano di uscire dalle gallerie per otto giorni e otto notti. Cittadini jugoslavi a tutti gli effetti, protestano contro gli emendamenti alla Costituzione del 1974 che di fatto hanno cancellato l’autonomia del Kossovo negando ai lavoratori del kombinat il diritto all’autogestione e alla maggioranza albanese la possibilità di scegliere propri rappresentanti politici locali. Parlano i minatori: “Protestavamo. Protestammo 800 volte a Pristina, Mitrovica, Vushtria, dappertutto. L’intero Kosovo protestava. Protestavamo, noi albanesi protestavamo, e si arrivò a un punto di rottura, era troppo. Non c’era altra soluzione che lo sciopero. Non ci permettevano di protestare in superficie, e così decidemmo di stare dentro, fummo tutti d’accordo, io lo dissi a te, tu a lei, lei a lui, buu, dentro. Buongiorno e buon viaggio!”

E ancora: “Jonuzi mi chiamò e mi precipitai… dovevo essere certo che l’elettricità non si interrompesse, e i ventilatori non si fermassero, perché senza ventilazione, senza aria, non è possibile stare in miniera neanche per un minuto.” È uno sciopero drammatico e disperato: intorno alla miniera e dentro la miniera si delinea la frattura che porterà alla fine dell’ esperienza jugoslava: tutta la popolazione albanese è al fianco dei minatori, mentre l’intera comunità serba assiste ostile al braccio di ferro e si chiude in un silenzio rabbioso.
Attenzione alle date: proprio in Kosovo, pochi mesi dopo questi avvenimenti – il 28 giugno 1989 – il presidente jugoslavo Milosevic pronuncerà l’incendiario discorso del Gazimestan (“nessuno più si azzardi a picchiare un serbo”) che fu l’inizio del decennio di sangue nei Balcani ed è considerato il primo atto della successiva dissoluzione jugoslava. Quell’estate fatale, quando il capataz di Belgrado comincia la sua folle corsa verso il suicidio jugoslavo e la balcanica “guerra delle fosse”, sui 1300 di Trepca era già calata la pietra tombale. Ingannati e poi perseguitati, spiati, picchiati, arrestati, fatti sparire. Così si concluse, fulminea come era cominciata. “Il 27 febbraio uno dei primi scioperanti a emergere dall’ingresso principale della miniera fu un minatore in stato di semi-incoscienza portato a braccia su una barella. Lo seguivano in piedi in quattro, reggendo il ritratto gigante del Maresciallo Tito. Dopo di loro uscì lentamente una lunga colonna di uomini esausti che avevano passato i sette giorni precedenti nel fango fino alle ginocchia a più di seicento metri sotto la superficie, al nono orizzonte della miniera.”

L’immagine ha la potenza dolente di un corteo funebre, un coro di tragedia greca: il sipario che cala su una storia gloriosa, sugli operai esausti, sulla patria comune e sul padre di quella patria: il Maresciallo Tito, leader della Jugoslavia socialista. Il resto - i giorni e i mesi che seguiranno - è il racconto di un’infamia. Gli operai sono stati traditi, i leader politici del Kosovo hanno mentito, i serbi hanno sete di sangue, a Belgrado i capi vogliono vendetta. Ad accogliere i minatori in superficie non fu il trionfo, ma una campagna di arresti e di intimidazioni, come una sentenza di massa per tutti gli scioperanti e i dirigenti della miniera. “Tre poliziotti alla porta, grandi, armati. Dicono in serbo: 'È qui il direttore generale? abbiamo ordine di invitarlo a un interrogatorio'. Io avevo già capito cosa stava succedendo. Lo svegliai, gli detti un paio di mutande di lana e una maglia a collo alto di lana, era come se gli mettessi un’armatura. Mi aspettavo che tornasse a casa perché mi avevano detto che lo avrebbero riportato. Mi ingannarono. Io continuai ad aspettare e aspettare.”
Era come se gli mettessi un’armatura, dice la moglie: è il racconto straziante di una discesa agli inferi, quello che squaderna Anna Di Lellio, scegliendo le interviste con i protagonisti dello sciopero raccolte dalla Oral History Kosovo in collaborazione con il programma del ForumZFD in Kosovo. Parlano gli albanesi, esclusivamente gli albanesi. “Nonostante i molteplici tentativi di raggiungere minatori o quadri serbi che fossero disponibili ad essere intervistati, non è stato possibile includere nel libro nessuno di loro”, scrive l’autrice. I minatori di Trepca sono sempre stati soli. Anna Di Lellio cita lo sciopero di tre giorni del luglio del 1981, quando i dipendenti incrociano le braccia per la busta paga decurtata del 16 per cento. Appena scatta la protesta, immediatamente si diffondono le voci di una agitazione non sindacale, non economica, ma anti-jugoslava: “Dietro lo sciopero di Stari Trg ci sono i nazionalisti!”, scrivono i giornali di Belgrado.

Anche quella di oggi è una storia di solitudine. Erano soli ieri gli albanesi vessati dai serbi di Milosevic, come sono soli i serbi schiacciati dalla maggioranza albanese che ora governa quelle terre. Il Kosovo intero - come ogni brandello separato di quella che fu una volta la Jugoslavia - è condannato alla solitudine e all’infelicità. Scrive Miljenko Jergovic: “Prima stavamo tutti in questa stessa terra, oggi questo paese è come un fazzoletto lavato male. Si è ristretto, è diventato piccolo, e tutti insieme non ci stiamo dentro.”
Storia, storia e ancora storia: la maledizione della storia. Di qui passò Rebecca West negli anni Trenta, anche qui raccolse alcuni degli episodi contenuti nel suo saggio fondamentale: “The Black Lamb and the Grey Falcon. A Journey through Yugoslavia.” A Mitrovica la scrittrice ritrae uno scenario insolitamente industriale, con i binari ferroviari, il borgo operaio e una collina bassa del “colore della morte” a raccogliere i rifiuti della miniera. La stessa collina, diventata ormai un monte, che negli anni Duemila incombeva sui poveri campi profughi degli albanesi. La stessa polvere nera, lo stesso veleno, lo stesso tradimento.

Perché – come ci racconta bene Anna Di Lellio – il mito stesso di Trepca industriale e socialista era una impostura. Il vanto della Jugoslavia di Tito e dei suoi successori fu il tipico esempio del sistema di imprese Jugoslavo, “caratterizzato da investimenti dispendiosi, crescita della produzione attraverso l’apertura di nuove fabbriche, bassa produttività e scarsi profitti coperti da sussidi statali.” È lo stesso tarlo, lo stesso peccato originale che produce il crollo dell’intero sistema comunista, a partire dal motore immobile dell’ Unione Sovietica: “L’impossibilità di modernizzare e democratizzare il paese nel pieno di una crisi economica, mantenendo una struttura politica comunista.”
Ma queste sono dissertazioni degne dei manuali di storia e di economia. Il libro di Anna Di Lellio ci parla invece di anime, di speranze e umiliazioni, di corpi. Come le parole e i corpi di Avdi, Zeki e Burhan, come i corpi dei quattro che portarono fuori della miniera occupata il gigantesco ritratto di Tito. Come – venti anni dopo – i corpi presto dimenticati delle bambine Gienita, Nikolina e Kasandra, intossicate dal piombo, avvelenate dalla stessa miniera, sotto la collina del “colore della morte.”
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI FOGLIEVIAGGI
© Tutti i diritti riservati


