Alla presenza di amministratori locali e rappresentanti del mondo delle Associazioni ambientaliste - ma con pochi esponenti politici e senza rappresentanti del Governo, evidentemente indaffarati in altre più rilevanti incombenze - è stato presentato il 3 novembre il Rapporto 2024 su “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, che l’ ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) elabora con cadenza annuale dal 2014. Il Rapporto certifica ancora una volta come, nonostante le tante parole spese sull’esigenza di dare risposte al cambiamento climatico e favorire un cambio di passo nel degrado ambientale, l’Italia si confermi un Paese in cui si chiacchiera bene, ma si razzola malissimo. In un solo anno, nonostante la valanga di affermazioni sulla volontà di salvaguardare il Belpaese, sono stati consumati altri 72 km quadrati, ovvero, in media, circa 20 ettari al giorno, 2,3 metri quadrati ogni secondo. Un incremento del suolo consumato solo leggermente inferiore rispetto al dato dello scorso anno. Comunque, al di sopra della media del decennio 2012-2022.

Nel periodo dal 2006 al 2023 abbiamo “consumato” oltre 128.934 ettari di territorio, dei quali 46.509 in modo irreversibile. Anche quest’anno, come già nel 2023, ampie parti del nostro Paese sono state sommerse dalle acque, altre devastate da venti che hanno toccato intensità di uragano e molte tra le più belle coste italiane sono state sfregiate dal mare in tempesta e da onde alte fino a 7 metri. Esondazioni, allagamenti, frane e drammatica erosione delle spiagge sono ormai, in Italia, fenomeni ricorrenti: non serve affrontarli con interventi “a babbo morto”, quando i fenomeni atmosferici hanno provocato danni per miliardi, ma andrebbero combattuti con una lungimirante e permanente iniziativa di protezione dell’ambiente e di messa in sicurezza dei territori. Invece accade questo: più protetto e meno sicuro è il territorio più sembra “logico” cementarlo. Altri 3600 ettari di aree a pericolosità idraulica, di cui oltre 1500 a pericolosità da media ad elevata, ricoperti di asfalto e cemento: da qui - fra le altre cause - nasce il dramma dell’alluvione romagnola di quest’anno, mentre le città diventano sempre più calde e impermeabili nonostante la crescita degli allagamenti dovuti alle sempre più frequenti “bombe d’acqua”. Solo per la riduzione dell’effetto spugna, ovvero della capacità del terreno di assorbire l’acqua e regolare il ciclo idrogeologico, ogni anno paghiamo a questo vero e proprio dissesto organizzato un tributo pari a 400 milioni di euro.
Sono oltre 2300 gli ettari di aree del territorio nazionale a pericolosità sismica consumati tra il 2022 ed il 2023, di cui oltre 200 in aree ad altissimo rischio, con il risultato che l’11 % delle intere aree sismiche pericolose del Paese è oggi cementato. E, per nostra “fortuna”, si è trattato di un periodo in cui neppure un mattone è ancora stato posato per quell’avventura irresponsabile – come ha attestato l’INGV – del Ponte sullo stretto, che proprio su una faglia attiva poggerà uno dei suoi pilastri. Nelle aree a pericolosità da frana si trova circa l’11% del suolo consumato nazionale (si arriva al 15,53% in Lombardia e al 15,43% in Piemonte), con un aumento di 529,8 ettari tra il 2022 e il 2023, di cui 37,7 in aree a pericolosità molto elevata (di questi 7,5 ettari in Emilia-Romagna) e 79,2 in aree a pericolosità elevata (dei quali 28,2 in Campania). Il consumo del suolo nelle regioni presenta casi eclatanti, quelli sopra il 10%: la Campania (10,57%), la Lombardia (12,19%) ed il Veneto(11,86%), con sfilate infinite di capannoni per la logistica, fabbriche vuote e mai riutilizzate e mega Centri commerciali. Emilia-Romagna, Puglia, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, hanno anch’esse valori sopra la media nazionale e compresi tra il 7 e il 9% Quanto alla logistica, solo nell’ultimo anno sono 504 gli ettari consumati, pressoché come l’anno precedente (505 ha), da sommare a un consumo cumulato dal 2006 di circa 5.606 ettari.

Quasi due terzi di questo incremento sono attribuibili all’espansione dell’indotto produttivo/industriale, mentre grande distribuzione/commerciale e strutture legate all’E-commerce contribuiscono entrambe per circa un quinto. Anche quest’anno i maggiori cambiamenti in peggio si verificano in alcune aree del Paese: il consumo si è concentrato tra il 2006 e il 2023 nel Nord-Est del Paese (+1.852 ettari, corrispondenti al 6% del totale del consumo di suolo per il periodo 2006-2023, dei quali 1.085 ettari in Lombardia), seguito dal Nord- Ovest (+1.703 ettari) e dal Centro (+1.011 ettari). All’aumento del consumo di suolo non corrisponde in alcun modo un miglioramento dell’efficienza logistica del Paese. Continua l’assenza di un qualsiasi strumento normativo nazionale o almeno regionale che impedisca la proliferazione anarchica degli insediamenti dovuta spesso solo alle esigenze di cassa dei Comuni. E non sono solo logistica ed edilizia a minacciare il suolo ancora libero: anche i pannelli fotovoltaici, sempre più, rischiano di divenire una minaccia per i campi e le attività agricole. I pannelli fotovoltaici a terra (+161 km quadrati), se si escludono le nuove aree di cantiere (classe 122), che rappresentano generalmente situazioni in evoluzione, rappresentano una porzione importante del nuovo suolo consumato reversibile, seppure con impatti diversi a seconda del tipo di impianto. A livello nazionale, dai dati SNPA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra circa 17.907 ettari, distribuiti in modo eterogeneo sull’intero territorio nazionale. Tra il 2022 e il 2023 sono stati rilevati 421 ettari di consumo di suolo associato a nuovi impianti fotovoltaici a terra, in forte aumento rispetto ai 265 ettari mappati nel 2022 e ai 76 del 2021.
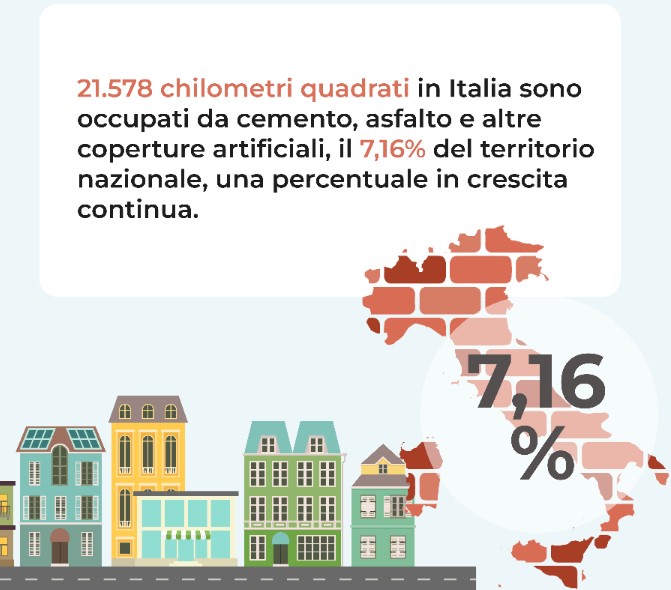
Singolare è il caso di un Comune alle porte di Cagliari, Uta, che risulta il comune con il maggiore incremento nazionale di consumo di suolo con ben 106 ettari, che già nel 2023 figurava tra i primi tre comuni per estensione di superfici artificializzate nel periodo 2021-2022. Un’enorme crescita, in gran parte attribuibile all’installazione di impianti fotovoltaici a terra concentrati nella zona industriale a sud del centro abitato. Alla fine, e rinviando alla lettura del rapporto, scaricabile, con tutti gli allegati statistici, a questo link, solo un paio di considerazioni politiche. Il Rapporto ci pone di fronte agli occhi un dato difficilmente ignorabile: “Nel caso in cui la velocità di trasformazione dovesse confermarsi pari a quella attuale anche nei prossimi anni, si potrebbe stimare il nuovo consumo di suolo, che sarebbe pari a 1.739 km2 tra il 2023 e il 2050 e a 451 km2 se l’azzeramento fosse anticipato al 2030. Se invece si dovesse tornare alla velocità media registrata nel periodo 2006- 2012, si sfiorerebbero i 3.000 km2. Nel caso in cui si attuasse una progressiva riduzione della velocità di trasformazione, ipotizzata nel 15% ogni triennio, si avrebbe un incremento delle aree artificiali di 371 km2, prima dell’azzeramento al 2030, o di 910 km2, prima dell’azzeramento al 2050. Sono tutti valori molto lontani dagli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 che, sulla base delle attuali previsioni demografiche, imporrebbero addirittura un saldo negativo del consumo di suolo”.

È proprio il Presidente dell’ISPRA Salvatore La Porta, nella sua introduzione, a ribadire che, nonostante il pregevolissimo lavoro e la messe di dati incontrovertibili che il Rapporto contiene, il problema resta eminentemente quello delle scelte valoriali e delle decisioni politiche: “In questo contesto, anche in considerazione della disomogeneità delle azioni sul territorio, sarebbe importante arrivare all’approvazione di una legge nazionale sul consumo di suolo in conformità agli indirizzi europei, che affermi i principi fondamentali di riuso, rigenerazione urbana, ripristino degli eco-sistemi degradati e azzeramento del consumo di suolo netto, sostenendo con misure positive il futuro dell’edilizia e la tutela e la valorizzazione dell’attività agricola. L’azzeramento del consumo netto di suolo è un obiettivo necessario anche per il raggiungimento dei target previsti dall’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano per la Transizione Ecologica (...) Arrestare il consumo di suolo nel nostro Paese permetterebbe di fornire un contributo fondamentale per affrontare le grandi sfide poste dai cambiamenti climatici, dal dissesto idrogeologico, dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, dal diffuso degrado del territorio, del paesaggio e dell’ecosistema, dalla perdita di biodiversità".

Sarebbe davvero interessante, a questo punto, chiedere conto a chi alla presentazione del Rapporto non c’era, come intenda operare per far rispettare la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 che ha introdotto due diverse modifiche alla Carta costituzionale: all’articolo 9, inserendo tra i principi fondamentali, un nuovo comma volto alla “tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e pone sotto la legislazione dello Stato la tutela degli animali; ed all’articolo 41, inserendo tra i diritti e doveri dei cittadini nell’ambito della libera iniziativa economica privata la previsione che essa debba svolgersi “in modo da non arrecare danno alla salute e all’ambiente” e che sia indirizzata e coordinata, oltre ai già previsti fini sociali, anche “ai fini ambientali”.
 MAURO SARRECCHIA
MAURO SARRECCHIA 


