Mi parli no …♫
Nel senso che nessuno parla più il dialetto milanese. Intendendo per dialetto milanese quella lingua che, con accenti e pronuncia diversi, si parla tra Milano e La Brianza.
Oddio, qualcuno ancora butta lì qualche parola o qualche frase. Ma è un vezzo, lo fanno più per sfizio. E quindi, facile sbagliare.
Qualcuno probabilmente ricorda la polemica che c’è stata qualche anno fa quando comparve un manifesto che avrebbe dovuto pubblicizzare il festival di musica classica MITO. Manifesto sul quale compariva la scritta :”Con Brahms, Mussorgsky e Ravel al Palasport tutt cos l'è bel!” Che è uno strafalcione, perché, in dialetto, per dire “tutto, ogni cosa” si dice “tusscoss”. Che è proprio un altro modo di pronunciare e anche di scrivere.
A me capita spesso di ascoltare testi di canzoni di giovani artisti. Qualche tempo fa mi è arrivato un bel CD, tra l’altro, di un gruppo che canta anche in dialetto milanese. In un brano cantano “me pias la mia dona quand la tira su la gona”. Allora, la gona in dialetto milanese non esiste. G’hè la sottana, el pedagn, la socca. Ma la gona propri no.
Ormai non si conoscono più nemmeno le regole fondamentali del dialetto. Per esempio la regola del plurale. Le parole che in dialetto finiscono in “in” al plurale escono necessariamente in “itt”. El cadreghin, (il seggiolino, il cadreghino): se ne avete più d’uno probabilmente siete un politicante e avete dei cadreghitt.

Tutto quanto sopra per dire che il dialetto va trattato con grande rispetto. Rispetto per le sue antiche radici e le sue nobili origini.
Prendete la cadrega, che saria la mama del cadreghin cioè la sedia. Cadrega viene dal latino “cathedra”, che era la sedia di quello che comandava: il trono insomma. Avete certo sentito l’espressione “il papa parla ex cathedra”. L’è no che ’l parla stando in pè su la scrivania. È che parla dal trono papale, quindi nella sua veste ufficiale e in quel caso si dice addirittura che sia infallibile.
C’è in dialetto un verbo bellissimo: “insubire”. Che ha due facce: una bella se ti insubiscono una caramella, una brutta se ti insubiscono una s’giaffa. Quindi promettere o minacciare, i due significati opposti. Che sono esattamente quelli dell’originario verbo latino “inexhibire”, che voleva dire presentare, offrire; ma prendeva consistenza a seconda di quel che veniva presentato/offerto.
Adesso c’è la moda di parlare inglese. Chissà se quelli che dicono “il mister” sanno che quel mister è stretto parente del nostro “maister” (il muratore). E che tutti e due sono figli del latino “magister”, il maestro. Persona importantissima: nel sostantivo magister sentite l’avverbio “magis” (di più) per indicare qualcuno/qualcosa che conta. No come el minister che invece c’ha dentro il minus (meno) perché el cuntava propri nagott.
Che bello: nagott, nec gutta, neanche una goccia contava il ministro. In latino.
Il rispetto naturalmente va attribuito a tutti i dialetti. Perché chi è orgoglioso delle proprie radici è rispettoso delle altrui. E i dialetti hanno tutti nobili origini.
Prendete il campidanese, un dialetto sardo. Lì, per dire la casa, dicono “sa domu”: ipsa domus, è latino classico.
In napoletano per dire che uno è a bolletta, non ha niente, si dice che “tene a capa 'e zi' Vicienzo”. La testa di zio Vincenzo. Che testa di cavolo aveva sto' zio Vincenzo che ha dilapidato tutti gli averi? Ma no. A capa 'e zi' Vicienzo non è altro che il “caput sine censu” del fisco dell’antica Roma che indicava colui che non aveva alcun bene. Grandioso. Rispetto.
Io invece il dialetto lo parlo. Lo parlo perché ho la fortuna di avere avuto la mia mametta che parlava normalmente in dialetto. Poi lei parlava anche un bell’italiano, perché ohé classe 1921, ma l’ha studiaa. Dopo i elementar l’è andada a l’Umanitaria a fa i tri cors de avviamento al lavoro: praticamente la laurea triennale. Ma lei, quando parlava con me, si esprimeva naturalmente in dialetto e io, quando parlavo con lei, mi esprimevo naturalmente in dialetto. Il dialetto è la mia lingua madre. In senso proprio.
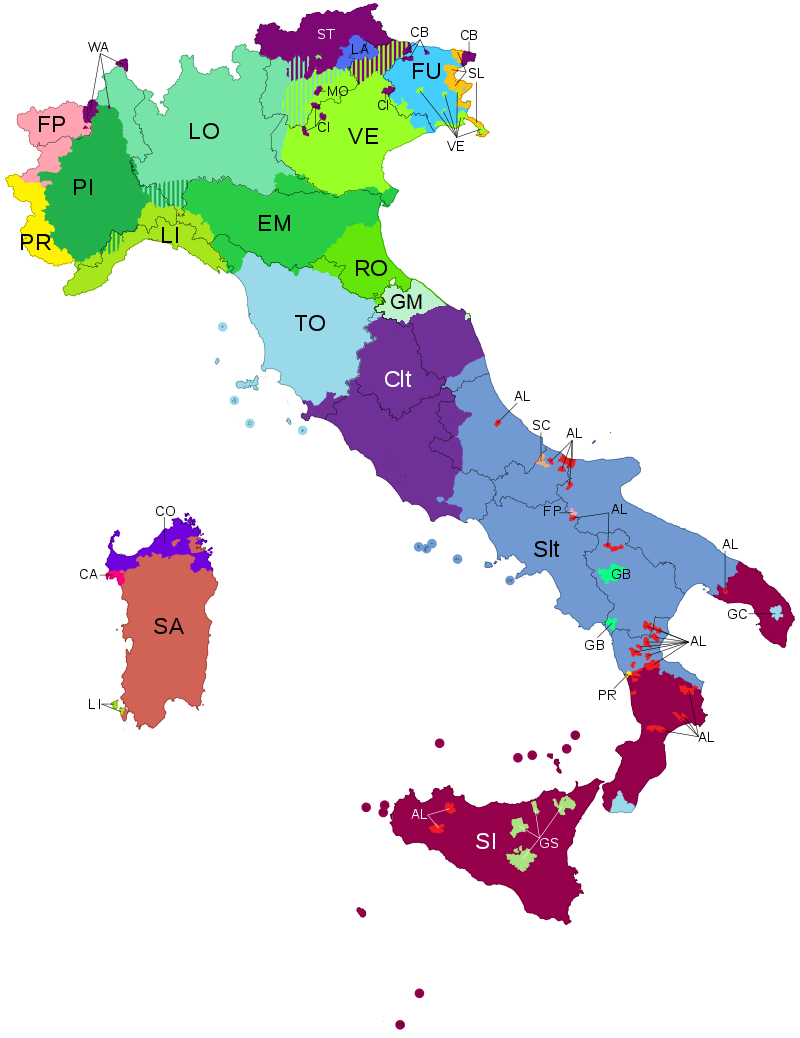
Da questa frequentazione quotidiana del milanese ho ricavato sorprese e curiosità straordinarie.
Prima cosa: esiste tutta una serie di parole dialettali che non hanno corrispondente in italiano. El bernasc o barnasc, come dicono in Brianza. Se andate a cercare sul Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, (il Vangelo, fin dalla prima edizione del 1839), alla voce bernasc trovate “paletta da fuoco”. Perché l’italiano non ha un sostantivo preciso per indicare quel preciso strumento che serviva per raccogliere braci e cenere nel camino. Il che vi dice, per inciso, quanto dovesse essere importante quello strumento per avergli attribuito un nome proprio.
O i catanai. Parola misteriosissima. Quando da bambini si giocava in casa, alla fine – come fanno tutti i bambini - si lasciavano in giro tutti gli oggetti che si erano utilizzati. Immancabilmente arrivava l’urlo della mamma: tirà su i tò catanai, mett via i tò catanai. Qui il Cherubini deve fare un triplo salto mortale e traduce “robe vecchie o che ingombrano, per lo più vili”. Verrebbe da dire cianfrusaglie, in italiano. Ma i catanai non erano solo cianfrusaglie. Per esempio l’artigiano, tè l’idraulico, chiamava semplicemente catanai-cianfrusaglie gli attrezzi da lavoro che portava nella sua capace borsa di cuoio. A proposito, l’idraulico è detto in dialetto trombee non per via della leggenda metropolitana secondo cui egli vada sempre a riparare i rubinetti alle signore quando non c’è il marito in casa. È detto trombee perché riparava le trombe. Che erano (ormai ghe n‘è pu) meccanismi idraulici che fornivano appunto acqua e terminavano con una uscita a forma di tromba. E che non avevano nulla a che vedere con il signor Falloppio.
Seconda cosa, il gusto popolare-dialettale di affibbiare soprannomi. Alle persone, senza malizia anche quando magari possono apparire un po’ cinici. Ricordo un distinto signore che, avendo perso un occhio durante la guerra, aveva un occhio di vetro e veniva chiamato dagli amici “œucc de sass”, che non è il massimo della finezza. Ma lui non si sentiva affatto offeso per quel soprannome utilizzato con assoluta bonomia: era il suo nickname.
Soprannomi alle famiglie, nati a volte da storie bellissime. Silva, il cognome della mia famiglia, è abbastanza diffuso tra Milano e la Brianza. Per cui, per distinguere i vari ceppi – i scepp – della famiglia Silva, si è fatto ricorso ai soprannomi. Così ci sono i Silva savonatt, perché le loro fortune sono iniziate con la produzione e il commercio di sapone. I Silva cadreghee, perché evidentemente qualche antenato fabbricava sedie. Il mio bisnonno faceva di mestiere el cavallant. Cioè partiva da Milano con carri trainati da cavalli – ecco perché cavallant – e andava fino in Austria, a Innsbruck, per caricare il legname che poi portava ai legnamee brianzoli. Andate a vedere su Google Maps il percorso tra Milano e Innsbruck: quattercent e passa chilometri lungo le valli del Trentino e le Alpi da scavalcare. Con carri trainati da cavalli, mica paglia. Quindi noi siamo i Silva che andavano a Innsbruck, che van a Sbruck, a Sbuck: siamo i Silva Sbuck.

Devo dire che da ragazzo un po’ me la prendevo quando mi mandavano a fare la spesa: entravo dal macellaio e questo qui appena mi vedeva: “tel chi el Sbuckin”. Sbuckin a me che frequentavo un prestigioso liceo classico a Milano e già mi vedevo come un raffinato intellettuale mitteleuropeo. Dai. Adesso naturalmente ho una nostalgia quasi dolorosa per quel soprannome.
E poi i giochi di parole. Magari con qualche doppio senso, sempre bonario anche quando suonavano un po’ piccanti. Pare esistesse veramente una ditta che produceva minuteria metallica (viti, bulloni e simili) i cui proprietari erano due soci: Menni e Agrati. Si raccontava la storiella del signore che, entrato negli uffici dell’azienda, si rivolge per informazioni all’impiegata: la me scusa, signorina ghè ‘l’Agrati? Risposta: no ma se’l spetta un moment ghè’l Meni.
E infine i proverbi. La atavica saggezza dei proverbi. Anche i proverbi in lingua contengono pillole di saggezza. Ma mi pare che in dialetto abbiano un sapore più fresco. Allora immaginate la civiltà contadina. Arriva l’inverno, fa un freddo bestia, fuori nevica – el fiocca – per cui i lavori nei campi sono sospesi. Ci si rifugia in stalla per sfruttare il calore animale. Il bue e l’asinello non l’hanno mica inventato per il Gesùbambino. Era proprio così: ci si riscaldava col fiaa de la vacca. Praticamente l’antenato dell’eolico. Ma poi, come sopravvivere ai rigori dell’inverno, come sopportare le lunghe noiose giornate invernali? Il proverbio suggeriva alcune generi di conforto. El pan d’on dì, il pane di un giorno, il pane fresco; el vin d’on ann, il vino di un anno, il vino opportunamente invecchiato; un tosa de desdott anni: qui chiedo scusa alle signore e signorine, ma il femminismo era di là da venire e comunque si possono sempre scambiare i generi; un capon e un’oca, un cappone e un’oca. Riassumendo: el pan d’un dì, el vin d’un ann, una tosa de desdott anni, un capon e un’oca e se’l ghà de fioccà digh ch’el fioca.
 di Antonio Silva
di Antonio Silva




