Sarà capitato anche a voi di trasformare un vostro viaggio in un mito, cioè in un racconto esemplare, fatto di avventure, pericoli, incontri inediti, peripezie sovrumane. Magari l’avrete fatto accompagnandolo con diapositive, brevi filmini, se proprio non siete grandi affabulatori. Ebbene, se volete fare l’esperienza inversa, cioè leggere di un mito raccontato con voce moderna, come se fosse un viaggio alla vostra portata, con rapide ed efficaci incursioni nell’attualità, affidatevi a Tommaso Braccini e al suo racconto del viaggio più pericoloso della Storia, quello degli Argonauti, copyright Apollonio Rodio. Braccini è un giovane e brillante antichista dell’Università di Siena, esperto di folklore e di racconti. Ha raccontato, fra l’altro, dell’orco e di vampiri, di miti vaganti, di aldilà e di lupi in fabula, facendo della Grecia antica e bizantina il punto di partenza per attraversamenti favolosi del mondo, fino ai nostri giorni. Leggere un suo libro è un piacere, come anche ascoltarlo dal vivo. E dunque, gli Argonauti: una sorta di compagnia di uomini leggendari, molti di più di una sporca dozzina o di un mucchio selvaggio.
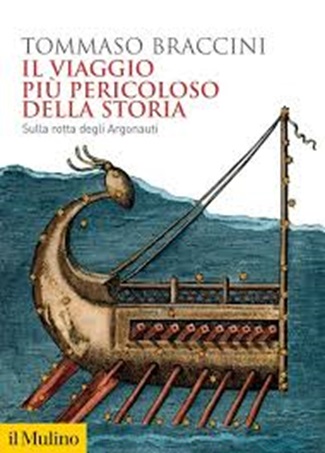
il Mulino, Bologna 2024)
Solo per fare qualche nome dei cinquanta (più o meno): Giasone, Orfeo, Meleagro, Admeto, Linceo, Teseo, Castore e Polluce, e naturalmente Eracle con Ila, il più giovane. C’era anche un Polifemo, ma non quello lì, no, era il figlio di un tale Elato, non di Poseidone. E forse non mancava una donna, fra tanti uomini (al ritorno ci sarebbe stata Medea, questa è cultura generale): nientemeno che Atalanta, la vergine guerriera e ottima velocista (qui non si parla di calcio!). Tutte figure legate a miti e racconti molto più ampi, che quindi si incrociano in digressioni e varianti che Braccini riesce a maneggiare e proporre con grande chiarezza. Mi verrebbe da dire che, come il timoniere della nave, Tifi, Braccini manovra un preciso timone temporale che gli consente di guidarci attraverso il tempo negli spazi moderni corrispondenti ai tanti luoghi toccati dagli Argonauti. E poi, una guida finale ai personaggi mitici menzionati nel libro risponde a tutte le vostre domande. Il viaggio, come si sa, partiva dalla Tessaglia ed era finalizzato alla riconquista del Vello d’oro, appartenuto a un ariete che aveva salvato Frisso ed Elle, i due figli del re di Orcomeno, Atamante. L’ariete era divenuto costellazione, mentre il Vello prodigioso era rimasto lì, nella Colchide, insomma sulle rive del Mar Nero, custodito da un drago. Se conoscete il nome della nave, allora avrete pensato anche al cane di Ulisse. E allora non potete perdervi uno splendido, breve, racconto di una grande grecista, Maria Grazia Ciani, con una nota di Claudio Magris: "Il racconto di un esilio: quello dell’autrice bambina da Pola dopo la Seconda guerra mondiale, nel quadro dell’esodo istriano (…) divenuto metafora della vita stessa". (Storia di Argo, Marsilio, Venezia 2006).
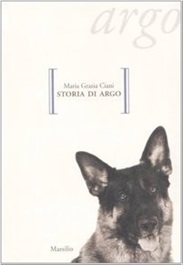
Sì, la nave si chiamava Argo, come il cane di Ulisse e come quel personaggio mitico, di stirpe divina, che aveva occhi sparsi su tutto il corpo; occhi che, alla sua morte, furono fissati sulle piume del pavone. Se, poi, consultate un dizionario di mitologia, troverete molti altri Argo, fra cui proprio il costruttore della nave, la prima nave mai costruita dall’uomo. Argos, in greco, significa ‘veloce’. Si capisce, dunque, che l’impresa degli Argonauti è pionieristica sotto molti aspetti. Ed è davvero toccante il racconto della partenza, perché "a un certo punto qualcosa attirò l’attenzione dell’equipaggio. Sulla riva erano comparsi il centauro Chirone e sua moglie Cariclo, che tra le braccia teneva il piccolo Achille, il figlio di Peleo, uno degli Argonauti. Era stato quest’ultimo, prima della partenza, ad affidare il proprio bambino al centauro (…) Il momento era emblematico. Il più grande degli eroi della nuova generazione, ancora in fasce, salutava il padre e i suoi compagni che vogavano verso Oriente in cerca di gloria, come avrebbe fatto anche lui vent’anni dopo".

Anche Nikos Kazantzakis, nella sua fantasmagorica Odissea (1938, trad. it. di Nicola Crocetti, 2020), offre al suo Ulisse
un equipaggio dai nomi parlanti e dalle differenti specializzazioni e attitudini: Capitan Conchiglia, Centauro, il Flautista,
il Bronzista, Granito, il Roccioso. Nel racconto di Braccini, antichi luoghi si inverano subito in meno noti e frequentati
siti della moderna Grecia e soprattutto delle coste orientali, ora turche (come due efficaci cartine illustrano a corredo
dell’Introduzione): come esempio greco, Orcomeno e Volo, per la cui rinascita turistica si potrebbe invocare la “legge”
di Vigata (Scicli) o di Palazzo Palladini (Napoli), fra Montalbano e UPAS. Ma torniamo al viaggio, che, fissati gli Antefatti,
si snoda lungo due parti: Partire e Viaggiare; Tornare. Osservo subito che Braccini sa come raccontare l’antico a un pubblico
moderno, richiamando spesso, come del resto immagino facessero gli antichi aedi con il loro pubblico, elementi di vissuto
e di cultura condivisa, senza nulla togliere alla ricchezza, alla precisione e alla profondità delle fonti.

Il titolo di un film (per esempio 'Gli uccelli' di Hitchcock o 'Conan il Barbaro' di Milius); un richiamo letterario o storico ("il gesto [di Medea verso Giasone] di porgergli quel pharmakon fu come la risposta data da Gertrude, la monaca di Monza, a Egidio, o ancor più come il passaggio del Rubicone di Cesare: il dado era tratto, e non si poteva più tornare indietro"); una comparazione intrigante e inattesa, per sottolineare un passaggio della Medea di un poeta latino della tarda antichità, Draconzio ("gli chiede [Medea a Giasone], neanche stessero flirtando davanti a un aperitivo, se sia sposato oppure ancora scapolo"): questa modalità arricchisce la fluidità narrativa, tiene desta l’attenzione alle tante diramazioni del racconto. Insomma, Braccini non indossa, come Machiavelli, “panni reali e curiali”, per entrare “rivestito condecentemente nelle antique corti delli antiqui huomini”; devo constatare che così, invece, fanno spesso molti (e molte) ri-raccontatori di miti, facendo rimpiangere gli originali. Ho immaginato Braccini come uno di quei compagni di viaggio che, con vestiti semplici ma adeguati, riesce a divertire, informare, far passare proficuamente il tempo con i suoi interventi. Non come Eracle, per esempio, che sembra invece, nella storia degli Argonauti, il compagno di viaggio ingombrante - un capitolo del libro è intitolato 'Per favore, fate scendere Eracle' - per la sua dirompenza. Ma non voglio spoilerare le tante versioni sulla sua effettiva partecipazione all’impresa.

Fatto sta che il viaggio è anche, raccontato in questo modo, un continuo trattato sottotraccia di geopolitica, soprattutto se si pensa che la Colchide - la mèta dalla quale si riparte, una volta conquistato il Vello, per il ritorno in Grecia - trova oggi, come Georgia, motivi di turbolenza legati all’ingerenza russa e alla propensione verso l’Occidente. La storia degli Argonauti, commenta Braccini, continua ad avere lì un valore identitario. E non manca la Libia col suo deserto, che gli Argonauti attraversano caricandosi sulle spalle la nave, come un Fitzcarraldo in anticipo di secoli.

In ogni caso, il ricco sostrato folklorico che Braccini colleziona nell’accompagnare il racconto del viaggio degli Argonauti
mostra come quella vicenda rappresenti anche una mappa della grecità passata, presente e futura. Il poema di Apollonio,
che scrive dopo Omero (Odissea) e dopo Euripide (Medea), ma racconta in qualche modo il prequel della tragica conclusione
del rapporto Giasone/Medea, così come del nostos di Ulisse (che passa dinanzi ad alcune tappe degli Argonauti), si ferma
a Iolco, all’arrivo dopo l’impresa. Tutto quello che riguarda Medea, che i moderni conoscono fin troppo bene,
accade dopo. Ma Braccini riesce a mettere una pulce nell’orecchio anche sul destino di questa figura che "gode ai nostri
giorni di una qualche rinomanza giornalistica". Anche in questo, caso, però, non voglio spoilerare.

Rimane da dire Cosa resta degli Argonauti, titolo delle conclusioni. Qualche pagina prima, Braccini aveva già dato conto, come spesso nei titoli di coda di un film, del destino dei singoli personaggi, anche in questo caso mostrando come i miti che conosciamo si siano ramificati e affermati, rispetto a un materiale perduto molto più vasto, anche per interessi localistici, capacità narrative, filtri della tradizione. Resta in primo piano la location, si potrebbe dire; il mare, vasto e profondo, che rappresenta la vera ambientazione pulsante di una “odissea addomesticata”.

Un mare che, suggerisce in conclusione Braccini, dovrebbe davvero ridiventare pontos, cioè passaggio, il passaggio pericoloso da aprire superando gli ostacoli, per renderlo disponibile a tutti. Impresa che non può competere a un uomo solo, a un Ulisse. Deve farlo un collettivo, una comunità intera. Molti anni fa un importante storico calabrese, Augusto Placanica (1932-2002), fece notare che "l’uso metaforico di odissea col significato di ‘una serie di avventure’ fu adottato alla fine del XIX secolo per rimpiazzare l’espressione allora più comune ‘un’iliade di disgrazie’ " (Storia dell'inquietudine. Metafora del destino dall'Odissea alla guerra del Golfo, Roma 1993, pp. 3-30). Forse sarebbe giunto il momento, per rendere omaggio ai magnifici Argonauti e indipendentemente dai loro singoli destini, che si parlasse di argonautica (al singolare, a rendere il plurale neutro greco) per elogiare un’impresa collettiva, difficile, ma vittoriosa. Ce ne vorrebbero davvero molte, di argonautiche.
 Gigi Spina
Gigi Spina 



