E se vi dicessi che ogni cura farmacologica è il risultato della creatività? Non nel senso di alchemia o di stregoneria. Non parlo di magiche misture o pozioni. Parlo invece di metodo e di impostazione mentale.
Sembra un controsenso, ma ora vi spiego.
La creatività è un processo mentale senza restrizioni o limitazioni che sconfina in ciò che non esiste già, nell’incertezza e nell’imprevedibile. Le scoperte scientifiche rivoluzionarie si sono avute quando i loro scopritori si sono avventurati fuori dai confini del sapere convenzionale e dagli schemi tradizionali. I nomi di Tolomeo e di Galilei vi dicono qualcosa?
Nel 2003 due scienziati (Dunbar e Fugelsang) si sono domandati quali siano i meccanismi neurali specificamente coinvolti nel pensiero scientifico, vale a dire in che modo la personalità e la psicologia dell’individuo potrebbero favorire le scoperte scientifiche...
Ebbene, circa il 35% delle scoperte scientifiche sono il frutto di serendipità, ovvero “… la capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte, specie in campo scientifico, mentre si sta cercando altro.” (Treccani)

Tant’è che capita spesso che i ricercatori scoprano cose che non stavano nemmeno cercando!
L’elemento cruciale quando si è trovata una soluzione a un problema annoso sta nel comprendere la causa della soluzione trovata e non la causa del problema, un procedimento mentale incerto e rischioso, e se evitare errori è un approccio rassicurante, di fatto uccide la creatività.
Il mondo attuale sembra essere il frutto di due, piuttosto recenti, shock che hanno segnato momenti di discontinuità rispetto allo status quo.
Al primo ci si riferisce come lo “Shock Sputnik” ovvero lo shock causato dall’Unione Sovietica agli USA con il lancio della navicella spaziale Sputnik nel 1957. Lo schiaffo morale inferto dette la sveglia all’intero popolo americano e avviò programmi di ricerca in ogni campo, che portarono, frettolosamente e per orgoglio nazionale, la NASA a completare i suoi numerosi progetti, che poi all’umanità hanno dato la moderna elettronica, internet e gli strumenti di comunicazione oggi insostituibili.
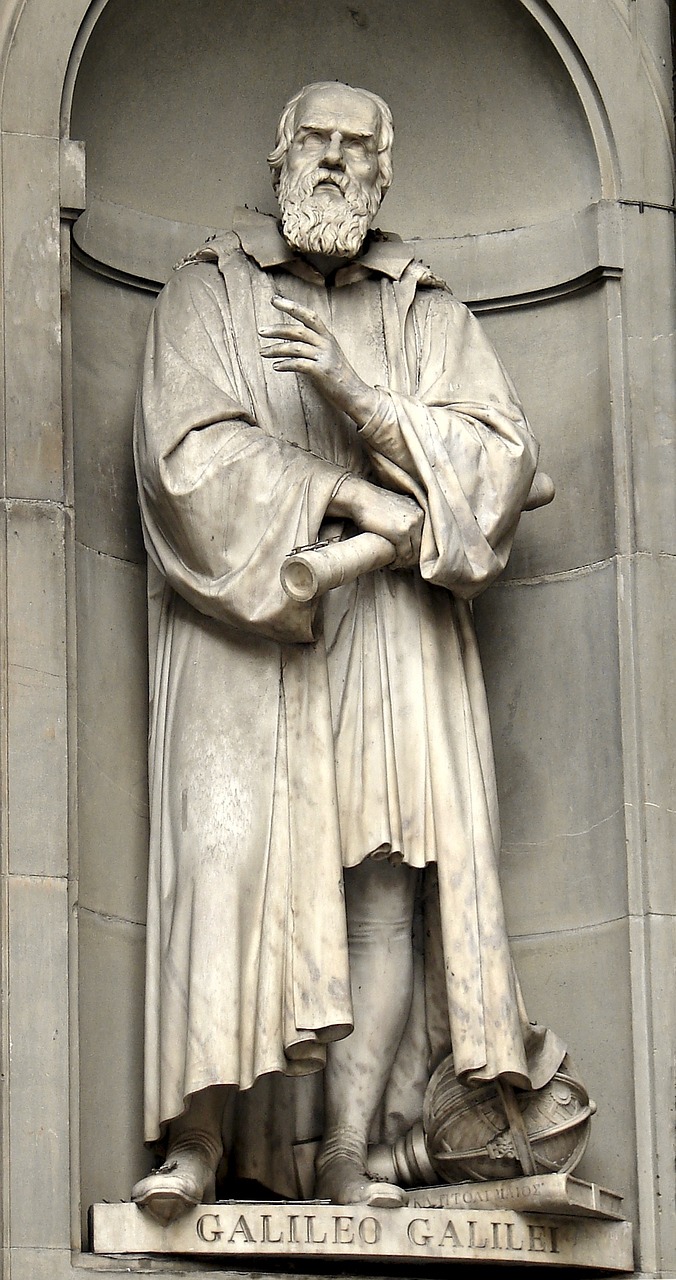
Il secondo è ancora in corso e va sotto il nome di “Cyber Shock”. E per comprenderlo dobbiamo rammentare la visionaria “Industria 4.0” (teorizzato dalla Germania nel 2011) che imponeva il ricorso alla moderna tecnologia finalizzata all’automazione industriale, che a sua volta è stata definita la “Quarta Rivoluzione Industriale.”
La portata sociale di Industria 4.0 è andata ben oltre la mitica catena di produzione e ha comportato radicali cambiamenti anche sul piano dell’istruzione, comunicazione, salute, agricoltura e tante altre aree al punto che Industria 4.0 si è evoluta in Società 4.0.
Non solo, ma si sta già parlando di “Quinta Rivoluzione Industriale” guidata dall’Intelligenza Artificiale (IA) e i CPS (Cyber Physical Systems) cioè sistemi informatici (ciberfisici) in grado di interagire con il sistema fisico in cui operano. Vale a dire ben oltre la “sola” automazione.
Infatti, si tratta più di integrazione tra mondo fisico e mondo informatico (cibernetico). Gli umani e le macchine stanno formando una coppia algoritmica che si influenza reciprocamente e i cambiamenti prodotti dalla tecnologia sono già diventati parte del nostro modo di pensare e di vivere, creando persino nuovi modelli sociali (pensate ai diversi modus vivendi di “GenX”, “GenZ etc).
In questo l’IA potrebbe addirittura rimpiazzare la creatività, rendendola pressoché superflua.
Tutte le rivoluzioni industriali avvenute ci hanno consentito di passare dalla locomotiva a vapore ai jet supersonici. Però diamo tutti per scontato il livello di sviluppo tecnologico che oggigiorno viviamo, e ignoriamo non solo il lavoro che c’è dietro ma anche il livello di interdipendenza tra le varie branche della scienza. Sebbene siano campi ben distinti, ognuno influenza lo sviluppo dell’altro e alcuni legami sono inaspettati e persino fantasiosi. Diventa quindi impossibile segnare una netta linea di divisione, e succede che lo sviluppo nella chimica dipenda anche dal progresso nella fisica, nell’elettronica o nell’informatica.
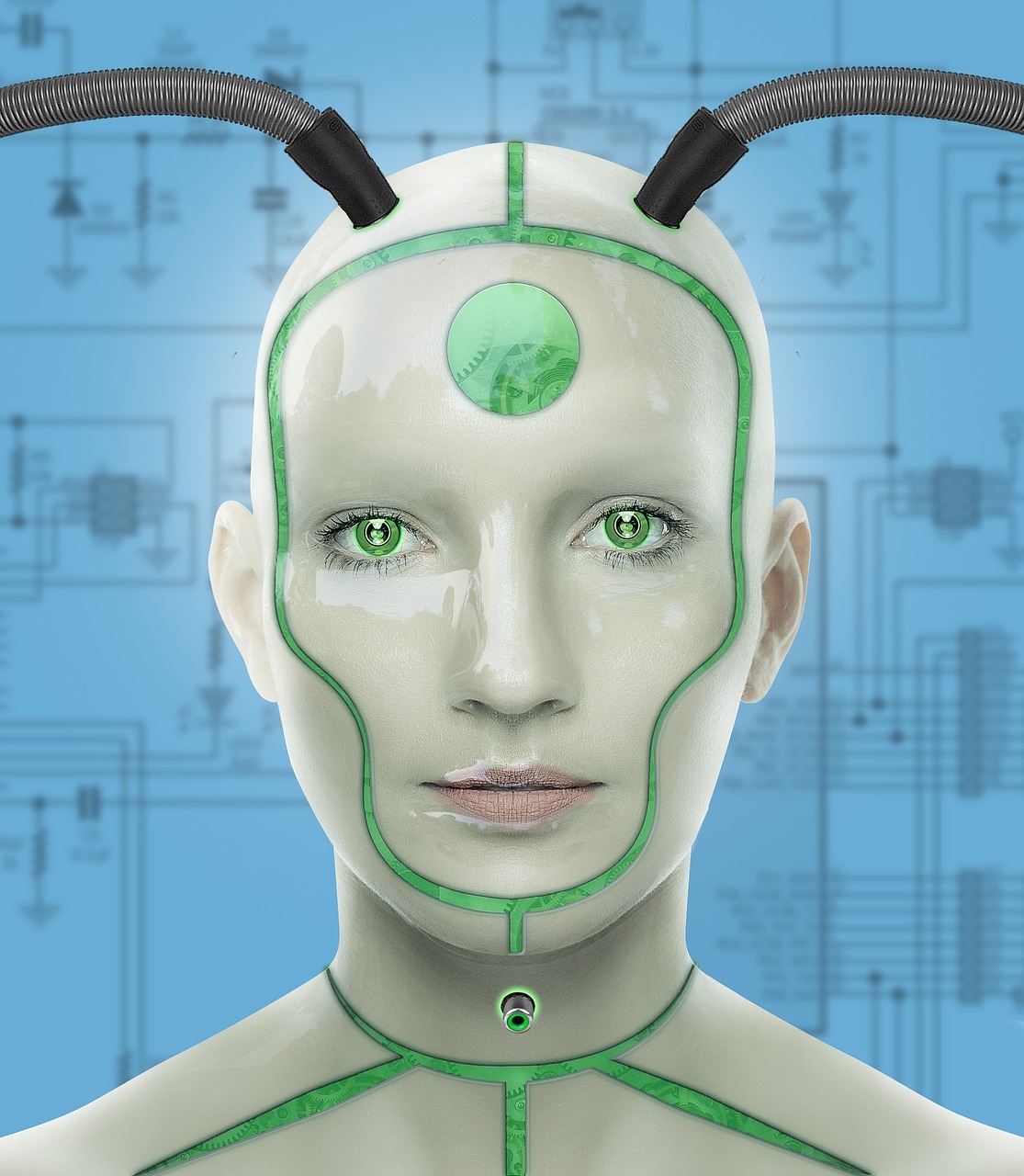
Siamo di fronte al dilemma dell’uovo e della gallina.
Microscopi sempre più potenti hanno reso possibile “vedere” nelle due direzioni: l’infinitesimamente piccolo e l’infinitamente lontano. Nuovi strumenti di misurazione sono in grado di rilevare suoni provenienti dal sottosuolo o dal cosmo. I confini tra geologia, biologia, chimica, fisica e astrofisica, elettronica e medicina sono diventati molto sottili. Se poi aggiungiamo le applicazioni nella vita quotidiana delle scoperte, scopriamo tanti vasi di pandora e cornucopie da gettarci in uno stato esistenziale di confusione mentale.
L’IA generativa non è un sistema creativo in quanto basato su dati esistenti. Non è in grado di agire fuori dalle istruzioni che le sono state date. (O almeno così ci dicono!) Ma, come abbiamo visto, le scoperte rivoluzionarie avvengono quando si sconfina dagli schemi prefissati.
Per le sue implicazioni sociali, legali, morali ed etiche, produttive, economiche o ecologiche, l’industria farmaceutica è tra le più complesse che mi vengono in mente. Ed è un’industria dove l’IA può dare un contributo notevole.
Non ci è dato sapere chi fu l’antico greco o egizio che scoprì gli effetti analgesici del salice piangente. Magari usando un ramo della pianta per togliersi un pezzetto di carne tra i denti, notò che gli passarono i dolori alla schiena. Abbiamo aspettato 2000 anni per poi definire l’acido acetilsalicilico come aspirina.
L’aspirina però è un toccasana per alcuni ma causa di decesso per qualcun altro, ed è questa peculiarità che rende l’industria farmaceutica complicata. Richiede non solo ricerca ma anche convalida sull’efficacia della molecola, in quali condizioni, per quali patologie, con quali dosaggio e quali controindicazioni. Quel foglietto illustrativo incluso nelle confezioni è il frutto di 10-20 anni di lavoro tra scienziati, medici, avvocati, e una quantità innumerevole di pazienti reali che creano una mole di dati, sotto forme di diagnosi, immagini, analisi di laboratorio, descrizioni di malattie, sintomi, condizioni fisiche, terapie, schede di produzione e conservazione, pareri legali nonché normative, leggi e disposizioni varie che non si possono nemmeno quantificare. E tutto ciò continua anche dopo il lancio del prodotto, dovendo ulteriormente raccogliere dati sull’uso del farmaco.

In tutto ciò, la tecnologia esistente e l’IA possono dare enormi vantaggi che vanno ben oltre la sola archiviazione e gestione dell’immensità dei dati, i cui benefici sono innegabili e immensi in termini di efficienza, precisione e costi.
Tuttavia, il contributo più importante si ottiene nelle fasi di ricerca e sviluppo delle molecole grazie alla possibilità di simulazioni computerizzate di esperimenti ed analisi di comportamenti nelle reazioni chimiche. Misurato in riduzione dei tempi di diffusione del farmaco un solo anno risparmiato può voler dire vite umane salvate.
E qui dobbiamo tornare al fattore iniziale, la creatività.
La “scoperta” di una molecola è già di per sé un processo complicatissimo. Lo scienziato che nota un comportamento inaspettato in una reazione chimica cercherà di capire le relazioni tra causa ed effetto alla base di quanto osserva. Una volta scoperto questo nesso, ipotizzerà quali potrebbero essere le condizioni che portano a quel risultato ed inizierà a pensare alla replicabilità del fenomeno e alla stabilità nei risultati, riuscendo così a definire un probabile campo di azione della molecola.
Se riprendiamo l’esempio del ramo di salice, il nostro ricercatore, stabilito il nesso tra la linfa della pianta e il dolore alla schiena, cercherà di capire se succhiare il ramo di salice, oltre ai dolori di schiena, serve anche per far passare i dolori di testa o alle ginocchia.
Ripetendo questo processo e incrociandolo con altri studi e sperimentazioni, il ricercatore “scoprirà” i possibili effetti dell’acido acetilsalicilico in altri campi, come ad esempio quello cardiologico e la possibilità di utilizzare la molecola come antitrombotico, per l’ipertensione arteriosa e altre cardiopatie.
Sapendo che nel mondo i decessi causati dalla formazione di coaguli nel sangue sono milioni, la molecola viene definita “promettente” sia sul piano medicale che economico e si avvia tutta la procedura di sperimentazione clinica, campionatura dei pazienti, e tutte le procedure previste per l’adempimento alle regolamentazioni nazionali ed internazionali (per definire i casi in cui si può utilizzare il farmaco) nonché per la produzione e diffusione del prodotto. (Chi lo pagherà e chi no, riguarda la politica e non la ricerca).

Gran parte di questi ultimi passaggi possono sicuramente essere svolti dall’IA, vista la sua capacità di svolgere analisi di dati in una frazione del tempo necessario ad un essere umano.
Lo stato dell’arte nella collaborazione tra “Big Tech” e “Big Pharma” è ancora in una fase esplorativa. Da un lato le case farmaceutiche, tradizionalmente caute, sono ancora alla scoperta di come utilizzare appieno l’IA. D’altro canto, le società tecnologiche, sebbene in grado di elaborare sofisticati algoritmi inquisitivi ed analitici, devono ancora perfezionarsi nell’analisi di dati medicali.
Il divario tra domanda e offerta non è abissale ed è solo questione di tempo perchè venga colmato; e la presenza di nomi come Meta, Google, Microsoft, Open AI, Nvidia, direttamente o con proprie società affiliate, dimostrano il potenziale di mercato nonché la potenzialità di scoperte all’avanguardia.
Ma senza quel “lampo di genio”, senza quella curiosità, senza quella formazione mentale di pensare fuori dagli schemi, insomma, senza quella creatività quei salti verticali che cambiano le regole del gioco sono poco probabili se non impossibili.
È come se, nonostante l’elevatissimo contenuto tecnologico che si porta dietro, l’IA fosse sì in grado di disegnare per l’Uomo una caverna più grande in cui vivere, ma sempre caverna rimane.
È la creatività che tira su un grattacielo, ma non ci siamo ancora.
(7 - continua)
 Luigi Epomiceno
Luigi Epomiceno 



